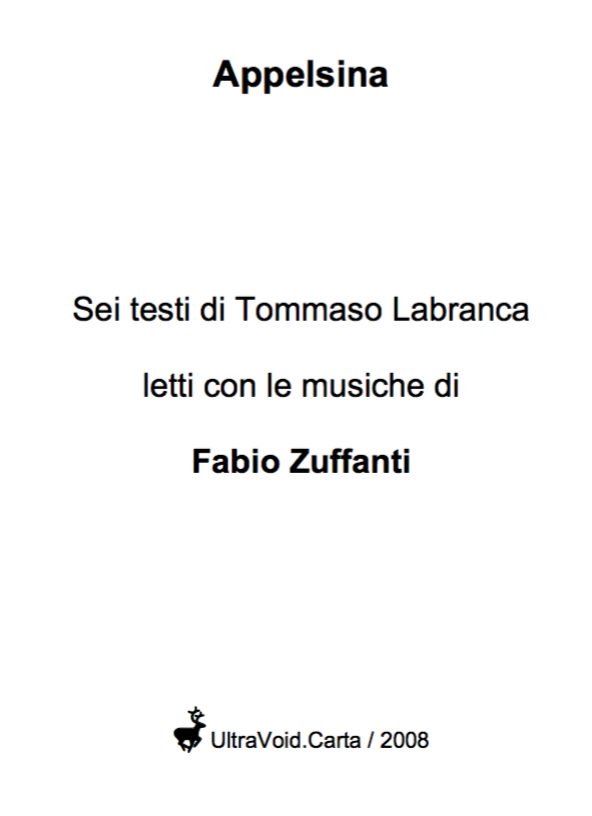
Tommaso Labranca – Appelsina
La neve che coincide con se stessa
Mi piace la neve che coincide con se stessa.
Mi piace la neve che non decora assurdamente una Palestina da musical, col bue e l’asinello tra i ballerini di fila e gli angeli che scendono da una scala illuminata.
Mi piace la neve che provoca sorpresa per qualche minuto e poi subito fastidio al traffico, alle scarpe non adatte, ai veicoli senza catene a bordo, ai funerali e alle gite scolastiche.
Mi piace la neve che non scatena un’ulteriore vacanza, quella che non va a posarsi sui lugubri portapacchi in ABS carichi di giacche a vento colorate.
Mi piace la neve su cui camminare silenziosi e mimetici e non sfilare urlando come volgari e inutili skateboarders.
Mi piace la neve che cade dal cielo solo come neve.
Mi piace la neve alle 6.30 del mattino del 1° marzo 1987 che copriva la strada davanti all’auto che mi portava non ricordo nemmeno dove. Perché nella memoria volatile che il cervello dedica alle cose inutili ho conservato solo le tracce delle scarpe e delle ruote che lasciavo su quel velo di poca neve inattesa e intonsa.
Mi piace la neve che immagino stia cadendo altrove, oltre la latitudine 59° 19’. Perché se cadesse qui e ora non sarebbe più un desiderio.
Myocastor coypus
Ho visto morte sulla strada due nutrie. Era un tratto con limite a trenta chilometri all’ora, ma chi era al volante non ha rispetto delle limitazioni né di certi roditori poco amati. Persino il WWF vorrebbe vederle morte per salvaguardare le fòlaghe più preziose.
I due animali erano mucchi di pelo poco più scuro dell’asfalto su cui giacevano.
Le nutrie provengono dal Sudamerica e la notte non riescono a stare a casa e sentono il ricambio del bombachito, del cupachito, del porachito… Allora lasciano le loro tane per andare a ballare in qualche locale di musica latino-americana fra i canali d’irrigazione e le marcite. Di notte le nutrie sceme si muovono con spavalderia perché ci credono tutti addormentati. Sono esaltate dal sapore della noche e finiscono sorprese dai fari delle vetture. Immobili al centro della strada, gli anabbaglianti che si fanno avanti. Non hanno mai visto nulla di simile e allora restano lì e pensano: è la Grande Luce! E’ la Grande Nutria Demiurga! E’… ma prima ancora di una terza ipotesi, le ruote con cerchi in lega le hanno già schiacciate. Nessuno torna indietro e quindi nessuno può fare vaste campagne di sensibilizzazione contro le stragi delle nutrie di notte.
Resto a guardarle con un dubbio. Saranno state investite insieme? Oppure dopo il primo evento, l’altra nutria si è avvicinata per prestare soccorso ed è stata travolta senza un lamento dalla Golf dell’ecuadoreño che seguiva la prima auto killer nel festoso corteo verso un chiringuito?
In fondo sono stato sempre nutria anche io in un mondo di fòlaghe preziose. Lo dice il WWF e anche il resto del mondo. Hanno ragione, ma adesso forse è meglio che io mi sposti subito dal centro della carreggiata. Per non seguire i due poveri animali nel paradiso dei roditori di seconda scelta.
Il XV Dalai Lama della Sfiga
Sono il XIV Dalai Lama della Sfiga. O meglio lo sono stato fino alle 15.10 di ieri pomeriggio quando ho rassegnato le dimissioni. In verità rassegnato lo sono sempre stato in questi ultimi quarant’anni.
Dal giorno in cui, chissà quando dove e come, il XIII Dalai Lama della Sfiga decise di passarmi il testimone.
La tradizione vuole infatti che lo stesso Dalai Lama della Sfiga vada in cerca del proprio successore. Il quale si renderà conto della cosa solo qualche anno dopo, lottando contro l’esercito dell’acne o gemendo davanti alle pubblicità per San Valentino, negli abbandoni del fine settimana o con la fronte poggiata a un optometro da un oculista impegnato a frenare il galoppo delle diottrie.
Ho cercato di venirne fuori, di diventare ricco e famoso come la signora J. K. Rowling, ma la saga che ho inventato è terminata prima di iniziare.
Avevo pensato ieri mattina di scrivere le avventure in più volumi di Rosicchio, un topo grigio e senza alcuna virtù. Ma mi è venuto fuori troppo scemo. Infatti, mentre ancora lo schizzavo nella mente e pensavo a come avrei speso i soldi dei diritti guadagnati, Rosicchio, per tenere fede al suo nome, ha rosicato il cavo d’alimentazione del computer sul quale stavo per scrivere le sue avventure. E mi è morto fulminato lì davanti, prima ancora che digitassi un incipit avvincente.
E allora basta… basta con l’onore di essere un Dalai Lama della Sfiga. Sono uscito di corsa e sono andato a un centro commerciale un po’ modesto. E il XV Dalai Lama della Sfiga era lì, come se mi aspettasse. Al reparto cancelleria. Avrà avuto circa quattro anni, seguiva il padre con la testa bassa, gli occhiali correttivi dalla montatura di plastica azzurra e teneva stretto al petto un album da colorare, 250 pagine 5 euro, con cui avrebbe passato il tempo che altri rivolgono ai palloni. E poi ti diventano Ronaldinho, altro che Rosicchio.
Mi sono avvicinato e mentre il padre non vedeva ho posto la mano destra sulla testa del bambino. Ho gridato: “Ce l’hai!” e sono scappato via.
Libretto grigio
Un giorno anche io riunirò i miei limitati pensieri in un libretto come fece Mao col rosso o il colonello Gheddafi con il verde. Ma il mio libretto non avrà un colore preciso. Sarà semplicemente stinto, desaturato. Chiunque nella copertina vedrà il colore che desidera. L’azzurro, il rosso, il verde oppure il giallo. C’è un punto nella mappa dei colori in cui tutte le tinte si spengono insieme. Per pigrizia molti chiamano quel punto grigio.
Ma il grigio è l’equilibrio tra le due grandi forze del bianco e del nero, è tutto quindi, invece di essere niente come molti credono, sbagliando.
Il grigio è la vita quotidiana, non perché noiosa assenza di colori. Perché la vita quotidiana è fatta di scelte mai precise, di azioni nere e malvage che si mescolano ad altre candide e umane. Punti bianchi di presunta solidarietà si sovrappongono nello stesso minuto a punti neri di egoismo automobilistico e formano quel liquido denso e grigio e fluido di cui è fatto un giorno come un altro.
Il colore che avrà la copertina del mio libretto di pensieri non sarà grigio, invece. Sarà una tinta spenta e addormentata. Era qualcosa un tempo, non ricordo neppure più cosa. Bisognerebbe sollevare la copertina e vedere all’interno cosa ci rivela. Come si fa con le tende di stoffa pesante, messe a proteggere le finestre da quel sole che le smangia e ne cancella il colore originale. E solo l’altro lato della stoffa sa dirci ancora se era blu o verde. Ma il mio pensiero è così sottile e consunto che ormai ha solo una dimensione e sarà impossibile andare oltre la copertina.
Nelle grandi biblioteche americane sarà comunque catalogato tra la letteratura grigia, definizione in uso in quel Paese per indicare la massa di documentazione tecnica, opuscoli informativi, libretti di istruzione, manuali d’uso e testi di filosofi che hanno poco da dire al mondo.
Il mese perfetto dell’anno
Il periodo perfetto dell’anno va dal 10 al 25 di gennaio. Per quel tempo la città è ormai spogliata dalle asimmetrie assurde delle feste e torna a svelare gli spigoli delle forme geometriche elementari di cui è fatta.
La città non è più scena per un Holyday On Ice, ma la semplice quinta di azioni utili e distratte, di eventi non straordinari.
Le luci sono solo quelle che servono e hanno solo funzione di illuminazione. Non sono antidoto colorato all’oscurità precoce dell’inverno.
Al mattino il ghiaccio è vero e acceca i parabrezza. Fa persino male alle mani e non è fatto di plastica o di spray come nelle vetrine. Incanta con la sua lucentezza, con gli asterismi più veri delle luci a rincorsa di duecento lampadine lasciate penzolare dai balconi.
Il periodo perfetto dell’anno si vive meglio dove c’è meno storia. Lontano dalle strade ornate dai palazzi asburgici del centro, dove l’architettura è basilare. In fondo alle strade create cinquant’anni fa da architetti comunali che ammonticchiavano parallelepipedi. In fondo a quelle strade, non più offuscate da luminarie a forma di agrifoglio, di stelle o caminetti si svela appieno l’iperneorealismo. Dell’agrifoglio hanno preso il posto gli alberi spogli e radi di zone verdi riservate ai cani. Tramontate le comete metalliche a cinque punte, sorgono i corpi celesti che per primi si accendono al crepuscolo (solitamente Venere). E poiché nessuno possiede caminetti negli edifici di edilizia convenzionata, il fumo esce condominialmente dai camini di impianti centralizzati. E si solidifica in sbuffi obliqui che più sono bianchi più vuol dire che fa freddo.
Ma anche se si gela continuo a camminare in questo campionario di geometrie per la scuola elementare. In questo periodo dell’anno le agende sono ancora tutte bianche e la mia forse ancora più vuota di quelle degli altri. Approfittando di questa assenza di impegni, potrei scatenare una rivoluzione. Perché spesso i rivoluzionari cambiano i nomi ai mesi e stravolgono i calendari. Suddividerei l’anno in due mesi. Il primo durerebbe molto poco, dal 10 al 25 di gennaio. Probabilmente lo chiamerei Perfetto. Il resto, di 300 e passa giorni, avrebbe come nome, forse, Uffa.
Senza falce, senza un occhio
Passavo molto tempo con un orso di peluche sintetico nel 67. Periodo di transizione anche per gli orsi di peluche. Non più ispidi plantigradi mitteleuropei, non ancora mostri elettronici che raccontano fiabe meccaniche. Non più soffici prodotti d’artigianato, non ancora pericolosi frutti di una Cina iperproduttiva e cattiva.
Era un orso un po’ confuso, ignaro del passato e incerto del futuro. Forse per questo gli volevo bene e lo stringevo a lungo. Non ricordo altro. Non ricordo nemmeno come passasse il tempo sul suo pianeta distante mio cugino. Bambino in negativo del mio stato, segnato da un DNA burino.
Quando passò a trovarmi con il padre, che poi era mio zio, avevo di sicuro quell’orso tra le braccia. Lo zio disse ridendo che i bambini non dovevano giocare con i peluche. Mi tolse dalle mani l’orsacchiotto e lo sbattè più volte a terra. Rimasi silenzioso e immobile mentre il cugino burino rideva. Vidi a un certo punto un occhio di vetro dell’orso schizzare dalla testa e finire su un mobile lontano. Poi i ricordi finiscono.
Saltiamo adesso insieme trentasette anni che ho vissuto un po’ confuso. Schiacciato dal passato e incerto del futuro. Saltiamo al momento in cui mi dissero che lo zio orsodistruttore era morto. Aveva sofferto molto, pare. Guardava verso il vuoto e diceva: non voglio venire.
Si lotta con la morte negli ultimi momenti di vita sulla Terra. Lotta soprattutto chi ha un DNA burino e troppo tardi cerca salvezza dalla pena per gli orsi massacrati nella vita terrena circondandosi di ritratti di frati truffaldini detti santi.
Ma la morte che immaginai sentendo quel racconto d’agonia non era quella con la falce e il manto nero. Né l’angelo barbuto dalla clessidra inesorabile. Sono sicuro che in quell’estremo istante lo zio burino lottasse contro un orso enorme e senza un occhio.
Mi sono consolato. Perché dopo lo strazio del mio gioco per oltre tre decenni io da sfigato avrò vissuto male. Ma lui sicuramente è morto peggio.
Un gioiello d’inverno
Fuori dalla finestra della cucina, una mosca aveva deciso di lasciarsi morire congelata. Aveva resistito un po’ aggrappata alla trama sottile della zanzariera, poi cadde improvvisamente sul davanzale.
Non l’ho vista quando ho aperto la finestra per spegnere una candelina ormai quasi esaurita. Mentre soffiavo verso l’esterno per non far restare il fumo in casa, la poca cera fusa rimasta nella base di stagnola si è riversata sulla mosca irrigidita.
Ho atteso che il freddo facesse rapprendere la cera per toglierla dal davanzale. Ma quando sono tornato con un coltello ho trovato la mosca trasformata in un gioiello d’inverno inconsapevole: nera, al centro di una massa bianca irregolare e translucida. Si distingueva appena, i dettagli erano sfumati, ma proprio per questo appariva più vellutata e preziosa.
C’era qualcosa che trasformava un insetto fastidioso e ripugnante in un oggetto che, magari posto su del velluto grigio, avrebbe destato l’entusiasmo di quale verboso venditore a Telemarket.
Era il pomeriggio del giorno di Natale del 2006, mi stavo annoiando e c’era fuori una nebbia fitta che avvolgeva tutto al centro di una massa irregolare e translucida. Presi la cera solidificata con la mosca al centro e la buttai in giardino.
L’ufficio bizantino
Credo che a volte nemmeno mi vedano. Non solo quando vanno tutti in pausa caffè e nessuno mi chiede di unirmi. Io non esisto perché non ho alcuna immagine sul desktop del mio computer aziendale.
E il mio tavolo è sgombro da tutto ciò che non serve al mio lavoro. Conservo i fogli extrastrong nel cassetto. Ho due matite gialle senza scritte e sempre temperate in un bicchiere di plastica trasparente. Non ho foto di figli, non ho foto di moglie né di altri parenti. Non attacco le sorpresine dell’Uovo Kinder sui bordi del monitor. Nessun gagliardetto di squadra di calcio. Né dive spogliate o biglietti di trasferte. Nessuna vignetta di satira politica ritagliata da un quotidiano di sinistra. Nemmeno da quotidiani di destra.
Il desktop del mio computer è una campitura aniconica di grigio, codice #c4c4c4.
Nascondo il cellulare sempre in una tasca, con la vibrazione attivata. E se per caso lo appoggio sul tavolo, si accorgono che è un vecchio Nokia 1100 display monocromatico. Non ha la possibilità di inserire sfondi.
Non racconto mai nulla dei miei fine settimana. Nulla delle mie serate. Però parlo del freddo se fa freddo. Del caldo in estate. Di pratiche e clienti. Spesso ascolto gli altri parlare e quando lo fanno compongono mosaici brillanti con tessere di vetro colorato, raffiguranti spiagge e palme, locali e scene di sesso, automobili. Mi sembra di vedere quei mosaici formarsi sulla parete dietro il distributore di caffè che diventa come un abside. E questo è il primo abside nel mio ufficio bizantino.
Il secondo abside musivo racchiude la collega grassa che ho di fronte per otto ore al giorno. Per sette organizza e millanta al telefono una vita mondana che sospetto inesistente. Per sei non l’ascolto nemmeno. Per cinque lei fuma anche se non si dovrebbe.
La sua massa apoplettica si staglia contro un cielo fatto di carta in cui non volano angeli, ma calciatori. Fotografati in campo o anche seminudi ai tropici o a Fregene. Ritagliati pazientemente dalla grassa collega che a loro spesso si rivolge con lo sguardo, volgendomi le spalle. A coronare l’affresco di rotocalco c’è un cartiglio stampato su modulo continuo che non dice Pax hominibus…, ma grida Siamo Campioni del Mondo.
Ho una collega grassa che si sente campione del mondo, ma fa l’assicuratrice.
Ho un lavoro di assicuratore anche io.
Ho un po’ di fantasia, anche se nessuno lo sospetta, guardando il piano vuoto della mia scrivania.
Se oltre a essere così noioso fossi stato anche boemo ed ebreo, magari avrei fatto il narratore.
© 2008 Tommaso Labranca / UltraVoid.carta
www.appelsina.eu www.tommasolabranca.eu www.zuffantiprojects.com www.myspace.com/fabiozuffanti www.myspace.com/tommasolabranca


4 commenti
Marta
grazie Antonella per quello che stai recuperando. ti abbraccio forte, vi voleva molto bene. Marta
anto
Cara Marta <3 cerco di trovare sollievo a questa tristezza infinita... credo di avere ancora molte cose, è un po' lungo perché sono pdf e necessitano di un minimo di formattazione, ma piano piano io metto tutto on line! Ho anche le registrazioni di un paio di interviste fatte a diverse radio, quelle devo trasformarle in video e metterle su you tube., ci arrivo vedrai! 😉
Anch'io gli volevo bene e credo lo sapesse.
Marta
io mi permetto di salvare tutto, abbiamo incominciato una lunga opera di catalogazione. è l’unico modo per riuscire a respirare nell’abisso in cui siamo caduti. ho perso una parte di me
anto
lo sto facendo per quello Marta salva salva salvati <3